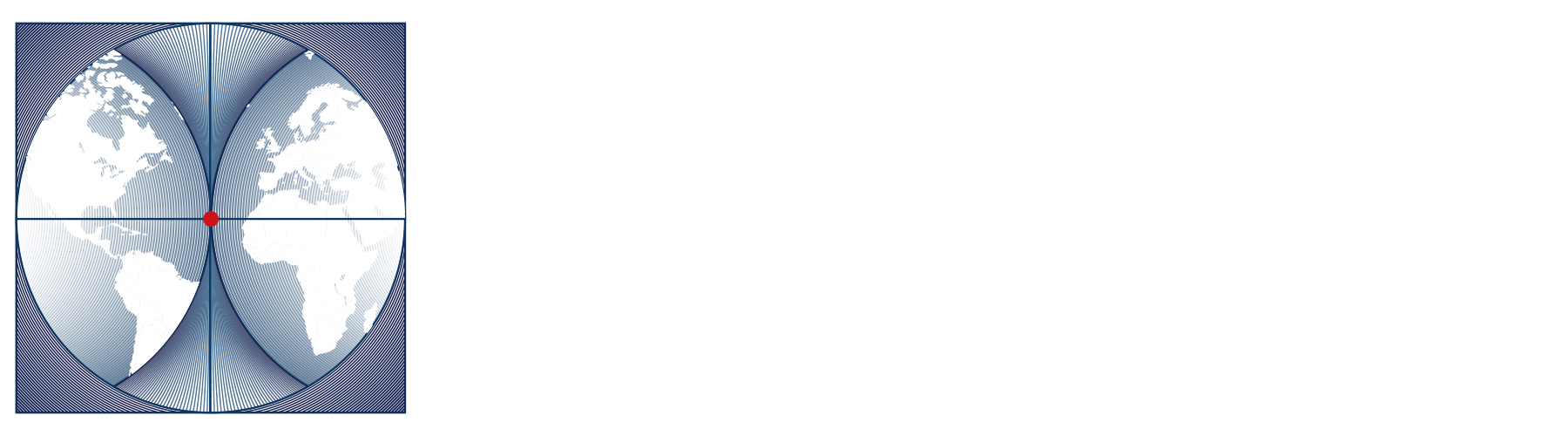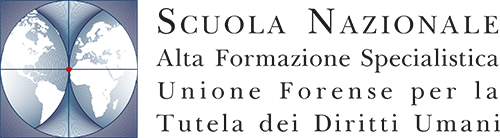di Massimo Benoit Torsegno
La pronuncia in esame si inserisce nel solco delle sentenze Talpis c.Italia e Landi c. Italia, emesse, rispettivamente, il 2/3/2017 ed il 7 aprile dell’anno in corso (anche se, in realtà, queste ultime, riguardando fattispecie nelle quali la violenza era sfociata nell’omicidio dei figli delle ricorrenti, avevano dichiarato la violazione dell’art. 2 della Convenzione), e conferma, purtroppo, come, nonostante il nostro ordinamento contenga un quadro completo ed articolato di misure dirette a contrastare la violenza domestica, ciò non sia sufficiente, nella pratica, a garantire sufficiente tutela alle vittime.
Nel caso di specie, successivamente alla separazione dal marito, la ricorrente era stata oggetto di ripetute violenze e minacce da parte di quest’ultimo, il quale, oltre a non corrispondere l’assegno di mantenimento ed a maltrattare i figli, l’aveva minacciata di morte, l’aveva colpita con il casco di una moto e si era ingerito nella sua vita privata, accedendo all’abitazione della stessa e ponendovi apparecchi di registrazione, sorvegliandone gli spostamenti, molestandola e sottraendole la corrispondenza.
Pertanto, la stessa, deducendo di aver presentato ben sette denunce (parzialmente archiviate e per una sola delle quali era stato disposto il rinvio a giudizio nel 2020) ed un ricorso civile per l’ottenimento di ordini di protezione (respinto sia perché non vi era coabitazione sia in quanto si era ritenuto che i comportamenti del marito dovessero essere iscritti nel normale contesto di una separazione conflittuale), lamentava la violazione dell’art. 3 della Convenzione sotto il profilo procedurale.
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che l’Italia non abbia adempiuto agli obblighi positivi, derivanti dall’art. 3 della Convenzione, di proteggere la ricorrente ed i suoi bambini dalle violenze domestiche, e richiamando, in particolare, in ordine al contenuto di questi, le raccomandazioni contenute nel rapporto sull’Italia redatto il 3/1/2020 da GREVIO, il gruppo di esperti incaricato di monitorare l’attuazione della Convenzione di Istambul, consultabile su https://www.coe.int/fr/web/istanbul-convention/italy .
Innanzitutto, la Corte ha confermato l’applicabilità dell’art. 3, rammentando come, ai fini ivi previsti, la gravità del trattamento dipende dall’insieme delle circostanze concrete, per cui esso può, comunque, essere qualificato degradante ove susciti nella vittima sentimenti di paura, angoscia od inferiorità, e ritenendo provato che, nella fattispecie, la ricorrente avesse subito violenza da parte del marito e che, come confermato dalle denunce e domande di protezione svolte, vi fosse il timore che tali comportamenti venissero ripetuti.
Inoltre, pur rilevando che, da un punto di vista generale, l’ordinamento giuridico italiano è idoneo ad assicurare protezione contro la violenza domestica e che il ventaglio di misure disponibili offre alle autorità possibilità adeguate e proporzionate al rischio specifico, ha, tuttavia, osservato che gli obblighi positivi a carico dello Stato Italiano comportavano, innanzitutto, una reazione immediata alla denuncia di violenza domestica, in secondo luogo, la valutazione circa l’esistenza di un rischio reale ed immediato, ed, infine, a seguito di quest’ultima, l’adozione di misure preventive, e che, al contrario, nel caso concreto, mentre i Carabinieri avevano valutato senza ritardo i rischi, chiedendo l’adozione di misure di protezione, la Procura non aveva dimostrato particolare diligenza nel rispondere alle allegazioni della ricorrente, senza prendere coscienza della dinamica specifica della fattispecie e senza valutare che le denunce svolte richiedevano un intervento attivo, violando, così, l’obbligo di svolgere un’indagine effettiva, il quale costituisce un elemento essenziale degli obblighi posti a carico dello stato dall’art. 3 della CEDU, sottolineando, anzi, a quest’ultimo proposito, la particolare diligenza richiesta nel trattare denunce di violenza domestica.
La Corte ha, poi, sottolineato come l’inerzia dell’Autorità Giudiziaria e la mancata adozione delle misure di protezione aveva creato, da un lato, un contesto di impunità per il marito (oltretutto non ancora giudicato per l’aggressione del 2015), e, dall’altro, aveva esacerbato la sensazione di ansia e di impotenza che la ricorrente provava a causa del comportamento minaccioso del marito, ritenendo, in conclusione, che lo Stato avesse mancato al suo dovere di indagare sui maltrattamenti subiti dalla ricorrente e dai suoi figli e che il modo in cui le Autorità avevano condotto il procedimento fosse sintomo di passività giudiziaria tale da non soddisfare le esigenze dell’art. 3 della Convenzione.