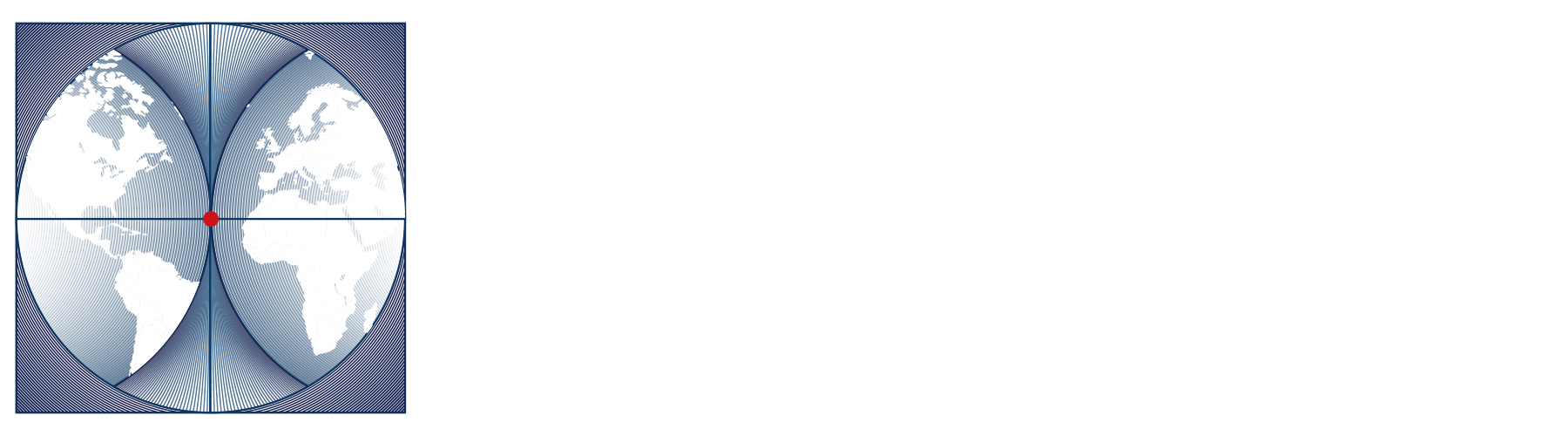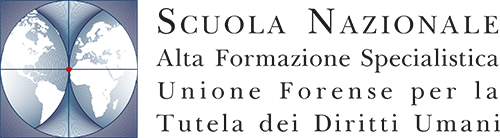di Emilio Robotti
La Corte di Strasburgo torna ad occuparsi dell’assistenza psichiatrica in Italia in ambito ospedaliero, prevista solo per ricoveri brevi e coattivo (T.S.O.) solo come estrema risorsa, allorché sia a rischio l’incolumità del paziente e/o di terzi, con una procedura apposita di convalida prevista dalla Legge denominata “Basaglia”.
Questo dopo aver trattato diversi casi – tra i quali Sy c. Italia – relativi alla detenzione di autori di reato con patologie psichiatriche destinati alle strutture di cura (REMS, nate per sostituire gli ospedali psichiatrici – OPG) che hanno visto, in una di tali occasioni, anche l’intervento amicus curiae dell’Unione Forense Tutela Diritti Umani (UFTDU), insieme alla Federazione Nazionale Strutture Comunitarie Psicosocioterapeutiche (FENASCOP).
Il caso Lavorgna contro Italia riguarda infatti il trattamento riservato al signor Lavorgna durante il suo ricovero in un reparto psichiatrico, effettuato in regime di T.S.O (Trattamento Sanitario Obbligatorio).
Al sig. Lavorgna fu diagnosticato un “disturbo psicotico non altrimenti specificato” ed era stato ricoverato il 30 settembre 2014, con il suo consenso, nel reparto psichiatrico dell’Ospedale Santa Maria delle Stelle di Melzo. Qualche giorno dopo il ricovero, il 7 ottobre successivo, ricevette una visita da parte dei genitori e in tale occasione espresse la volontà di essere dimesso. Dopo che lo psichiatra dell’Ospedale, a tale (legittima) richiesta, rispose che avrebbe dovuto rimanere in ricovero per altri quattro giorni, sia per consentire la remissione dei sintomi che avevano reso necessario il suo ricovero, sia per completare la rivalutazione della sua terapia farmacologica, il lsig. Lavorgna – secondo quanto registrato nella cartella clinica di ricovero – reagì aggredendo fisicamente il padre, la madre e lo psichiatra dell’ospedale.
A seguito di tale aggressione, lo staff medico dell’ospedale decise quindi di applicare al sig. Lavorgna una contenzione meccanica, presentando una richiesta di convalida del ricovero – a questo punto non più volontario – dichiarando che il paziente aveva aggredito i suoi genitori e un medico, ma che non era consapevole delle sue azioni e che aveva dovuto essere costantemente trattenuto. La richiesta di ricovero fu reiterata, ed il signor Lavorgna fu tenuto in stato di contenzione per quasi otto giorni e comunque sotto sedazione farmacologica fino al suo trasferimento in un altro ospedale, avvenuto il 27 ottobre 2014.
Nel novembre 2015, il sig. Lavorgna presentò una querela contro due medici dell’ospedale di Melzo, denunciando maltrattamenti, falsa detenzione e coercizione criminale a causa, tra l’altro, della presunta mancanza di giustificazione e del lungo periodo – quasi otto giorni – in cui egli era stato tenuto in contenzione continuativa legato al proprio letto; che il trattamento ospedaliero era stato somministrato in modo inumano e degradante, causandogli intense sofferenze fisiche e psicologiche.
Il trattamento, sostenne il sig. Lavorgna, era sproporzionato rispetto alla sua condizione clinica, sottolineando il fatto che i due medici avevano ammesso di non essere competenti e che la struttura ospedaliera non era attrezzata per occuparsi di lui durante il ricovero obbligatorio. Il Sig. Lavorgna sostenne anche di essere stato legato in attesa di un “pentimento” per le sue azioni, piuttosto che per l’acquisita consapevolezza del proprio comportamento, il che equivaleva a conferire alla contenzione un fine “pedagogico” della contenzione, ritenuto illegittimo dal Comitato per la Prevenzione della Tortura.
Nel febbraio 2016, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano nominò un perito per valutare la situazione. La relazione del perito nominato rilevò che le misure di contenzione erano state eseguite a seguito di un atto di violenza specifico, ma che il periodo di contenzione era stato insolitamente prolungato.
Nel febbraio 2019, il Pubblico Ministero chiese l’archiviazione del procedimento, accolta nel luglio 2020 dal G.I.P. del Tribunale di Milano, con la motivazione che “i medici non hanno commesso alcun errore di pratica terapeutica, (e) hanno rispettato le linee guida e i protocolli applicabili al caso specifico”; che il signor Lavorgna era stato “attentamente valutato quotidianamente dal personale medico, per cui non c’era stata alcuna negligenza o superficialità” nel corso del suo ricovero.
Il Sig. Lavorgna presentò quindi ricorso alla Corte di Strasburgo per violazione dell’Articolo 3 della Convenzione (divieto di trattamenti inumani e degradanti) con riferimento alle modalità del proprio ricovero ospedaliero psichiatrico e anche sotto il profilo di un’inadeguata indagine delle Autorità alla sua denuncia.
Superato il vaglio della valutazione di ammissibilità del ricorso, nel corso del procedimento davanti alla Corte sono stati autorizzati gli intervento di terzi del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale italiano, delle associazioni L’altro Diritto ODV e La Società della ragione ONLUS.
La Corte ha accolto il ricorso del sig. Lavorgna, condannando lo Stato italiano.
Nella Sentenza la Corte ha rilevato essere pacifico il fatto che il signor Lavorgna sia stato privato della libertà mediante contenzione meccanica, legato con cinghie ai polsi ed alle anche, al proprio letto per quasi otto giorni e che sia stato sotto il controllo e la responsabilità dello Stato durante il suo ricovero in un ospedale psichiatrico. Pur ritenendo la Corte che l’ordine iniziale di applicare la misura di contenzione fosse necessario per evitare che il signor Lavorgna facesse del male a se stesso o ad altri, la sentenza ha ribadito che spettava allo Stato dimostrare la condizione della stretta necessità della contenzione e che tale condizione fosse stata soddisfatta, non essendo sufficiente un pericolo solo “potenziale” per applicare la restrizione della libertà. Infatti, ha osservato la Corte di Strasburgo, la stessa giurisprudenza della Corte di Cassazione italiana vieta la pratica delle misure di restrizione “precauzionali” e il Comitato per la Prevenzione della Tortura ritiene che qualsiasi restrizione della libertà in ambito ospedaliero, di durata superiore anche a poche ore, dovrebbe essere rivista da un medico a intervalli regolari.
Per quanto riguarda l’indagine seguita alla denuncia del signor Lavorgna, ha motivato la Corte, essa non aveva affrontato nè le questioni relative al prolungamento per un periodo così lungo della misura di contenzione iniziale, né aveva affrontato le sue argomentazioni in merito al fatto che il suo essere stato legato letto non costituiva un itervento come “ultima risorsa”, a maggior ragione considerando che i protocolli ospedalieri prevedevano altre misure da applicare prima della contenzione.
Inoltre, ha osservato sempre la Corte, l’ultimo giorno in cui il signor Lavorgna era stato legato, due medici del servizio psichiatrico avevano richiesto la continuazione delle sue cure “in un contesto più appropriato”, perché non attrezzati per affrontare ciò che avevano considerato come un “pericolo sociale” e dichiarando che il proseguimento della contenzione del signor Lavorgna era stato problematico da gestire e “eticamente discutibile”. Fatto, quest’ultimo, che la Corte ha ritenuto estremamente preoccupante.
Lo Stato Italiano non ha dimostrato, afferma la decisione in esame, che fosse strettamente necessario il lungo periodo di contenzione; contenzione che aveva esposto il signor Lavorgna al dolore e alla sofferenza, in violazione dell’Articolo 3 della Convenzione.
La Corte ha ritenuto che non fosse necessario esaminare il reclamo del signor Lavorgna relativamente al suo trattamento farmacologico, avendo già affrontato la principale questione giuridica sollevata dal caso.
Per quanto riguarda l’indagine chiesta dal ricorrente alle Autorità italiane, la Corte ha ribadito che l’obbligo di svolgere un’indagine efficace sulle accuse di un trattamento che viola l’Articolo 3, subite per mano di agenti statali, è consolidato nella giurisprudenza della Corte. Nel caso del sig. Lavorgna, la Corte ha notato che invece erano trascorsi tre anni e quattro mesi, dalla denuncia penale alla richiesta di archiviazione; che non c’erano prove che fossero state svolte indagini istruttorie, come la raccolte testimonianze, o compiuti altri atti investigativi; che tra la perizia medica disposta e la richiesta di archiviazione era trascorso un periodo di tempo significativo; che i tempi della procedura erano stati eccessivamente lunghi e senza alcuna giustificazione di tale durata. La Corte ha pertanto riscontrato una violazione dell’Articolo 3 anche sotto tale profilo, riconoscendo al ricorrente, a titolo di equa soddisfazione secondo l’Articolo 41 della Convenzione, la somma di € 41.600,00 per il danno non patrimoniale e di € 8.000 a titolo di spese.