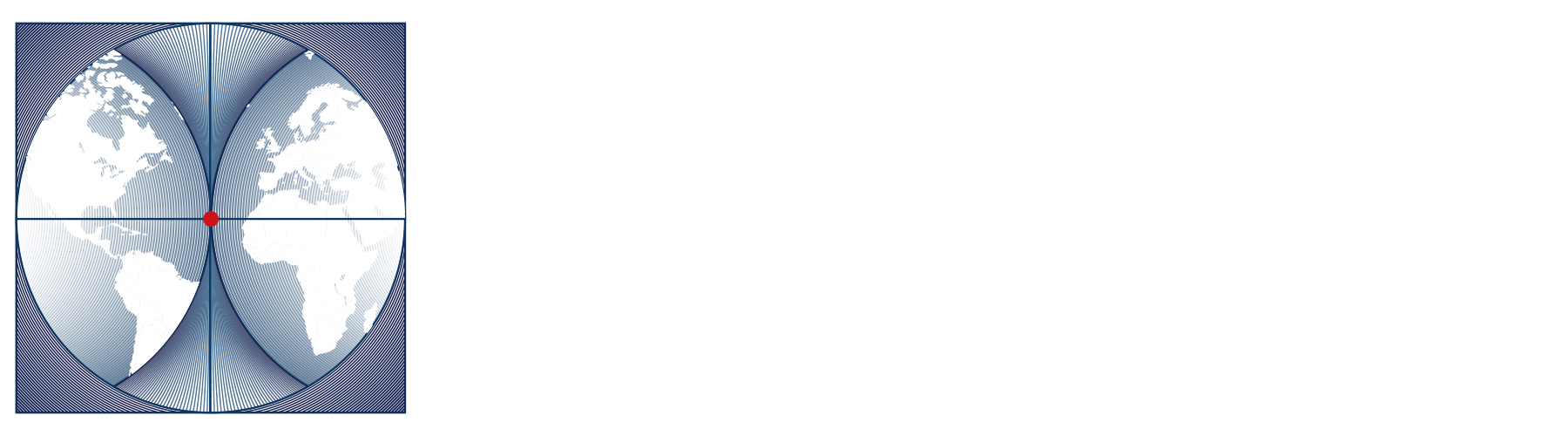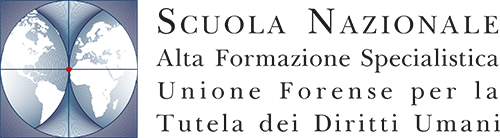di Gaetano Di Muro
Non si era ancora pienamente diffusa la sconcertante notizia della sentenza “ammazzaricorsi” 1.6.2021 n. 15771 delle Sezioni unite, che ecco proporsi la pacata riflessione, prima ancora del popolo dei giuristi, della stessa Corte di Cassazione (Sezione terza, Ordinanza 23.6.2021 n.17970, presidente-estensore Travaglino) che, a fronte dell’insormontabile principio di diritto, costituente ormai diritto vivente, affermato dalle Sezione Unite, ritiene inevitabile la rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. art. 35 bis, c.13 d.lgs. n. 25/2008 così come interpretato dalle SS.UU., che ravvisa nella norma in questione “una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore”
Avverte la Sezione che la rimessione alla Corte non è funzionale ad una (impossibile) pronuncia volta ad una interpretazione difforme rispetto a quella adottata dalle sezioni unite con la sentenza 15177/2021, bensì ad “una valutazione di costituzionalità della norma, nella sua portata di diritto vivente, proprio per effetto di tale pronuncia “.
L’articolata ordinanza, meritevole di attenta lettura, ritiene che tale disposizione, così come interpretata, violi, con i principi di razionalità, sia la nostra Costituzione, sia la Carta dei diritti UE. In particolare, risulta contraria agli artt. 3, 10, 24, 111 della Costituzione e all’art. 117 Cost. in relazione alla direttiva 2013/32/UE con riferimento agli artt. 28 e 46 § 11 e contrastante con gli artt. 47 della Carta dei diritti UE, 18 e 19, §2 della medesima Carta, 6, 7, 13 e 14 della CEDU. Sebbene implicito, aggiungerei l’art. 3 della Costituzione con riferimento all’art. 16 comma 2 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo Statuto dei rifugiati, che parifica questi ultimi ai cittadini.
L’Ordinanza va letta. Essa è ricca di spunti di riflessione.
Per citare solo alcuni dei più rilevanti, la Sezione evidenzia, sotto il profilo dell’esegesi testuale e della ragionevolezza, che l’art. 35, nella sua formulazione letterale, riserva la sanzione dell’inammissibilità al solo presupposto della posteriorità del conferimento della procura rispetto al provvedimento impugnato (“la procura alle liti ..deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato;”), ma non anche alla certificazione della data del rilascio: Infatti, avverte la Sezione, il sintagma “a tal fine” appare, sul piano lessicale, oggettivamente riferito al requisito della posteriorità della procura rispetto alla data del provvedimento impugnato (“a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”). Sicchè, alla luce di un’interpretazione letterale della norma (ubi lex voluit, dixit), la certificazione della data non è richiesta a pena di inammissibilità nè, in mancanza di una espressa disposizione, è possibile che tale gravissima sanzione processuale sia ricavabile aliunde in via presuntiva. Consegue che “Il fine” di certificazione della data che la norma si prefigge, ben potrebbe realizzarsi aliunde, sia confrontando la data del provvedimento impugnato con quella del mandato, sia desumendo la data del rilascio dall’autentica della firma, “in ossequio al principio della strumentalità delle forme processuali e del raggiungimento dello scopo”, più volte affermato dalla Cassazione, anche a sezioni unite.
Conclude sul punto la Sezione che la mancata certificazione della data “posteriore”, comunque risultante dall’atto, costituirebbe una mera irregolarità, “non essendo le forme processuali prescritte per la realizzazione di un valore in se, ma per il perseguimento di un certo risultato, onde l’inosservanza di un requisito formale risulta irrilevante se l’atto viziato ha ugualmente raggiunto il suo scopo” (così, testualmente, Cass. 24990/2021, cit.).
Passando all’esame critico della ratio legis posta a fondamento della decisione delle Sezioni Unite (e quindi della norma), la Sezione rileva che l’onere, a carico del difensore, di separata certificazione della data di rilascio della procura, duramente sanzionato con l’inammissibilità del ricorso del richiedente asilo, non solo non appare essenziale per l’accertamento della posteriorità del rilascio rispetto alla pubblicazione del provvedimento impugnato, ma risulta, per molti versi, estraneo al sistema, illogico e contraddittorio, sia con riferimento al ruolo dell’avvocato confermato sin qui dal codice del 1940 e alla sua limitata funzione certificatoria della identità personale del sottoscrittore del mandato in suo favore, sia in relazione al possibile abuso di mandati in bianco che, ove accertato, costituisce chiara violazione -non solo deontologica- dei doveri professionali, imputabile al professionista, ma non riversabile sugli immigrati, mediante una funzione “deflattiva” destinata a colpire, attraverso la sanzione di inammissibilità dei ricorsi, i loro diritti soggettivi e talvolta la loro stessa sopravvivenza. Senza considerare che l’avvocato aduso ad autenticare i mandati apponendo date fittizie, continuerà a farlo “certificando” date fittizie.
D’altronde, al di là della illogicità di desumere la prova della persistenza dell’interesse (al diritto alla vita) dalla permanenza in Italia del ricorrente, il sistema risulta irrazionale lì ove, da un canto, impone la permanenza in Italia dello straniero e dall’altro, eliminando l’automatica sospensione del provvedimento impugnato, ne consente l’espulsione o l’allontanamento. Con l’ovvia conseguenza, evidenziata dalla stessa dottrina solo in parte evocata dalle SS.UU., “che se il ricorrente, nei casi in cui la sospensiva non è prevista automaticamente ovvero non è stata concessa, è stato espulso oppure si è allontanato dall’Italia, non può rilasciare la procura al difensore il per ricorso in Cassazione (a meno che il difensore lo raggiunga nel Paese in cui si trova)”.
Quanto poi alla violazione dell’art. 3 Cost. (aggiungerei: anche in riferimento all’art. 16 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo Statuto dei rifugiati, secondo cui “nello Stato Contraente in cui ha la sua residenza abituale, ciascun rifugiato fruisce dello stesso trattamento concesso ai cittadini di detto Stato”), la Sezione, dopo aver richiamato il “recente insegnamento” (Corte cost. n. 186 del 2020), secondo cui “il dato letterale del riferimento ai “cittadini” contenuto nell’art. 3 Cost. …. risulta da tempo superato dall’interpretazione che reputa tale principio operante anche per gli stranieri tutte le volte in cui si tratti di tutelare diritti fondamentali. Di qui, la conseguenza che non è consentito al legislatore introdurre regimi differenziati circa il trattamento da riservare ai singoli consociati se non in presenza di una causa normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitraria (Corte cost. n. 432 del 2005)”, la Sezione critica la tautologica affermazione (delle SS.UU.) secondo cui “non vi è alcuna materia regolata dal diritto interno omogenea a quella della protezione internazionale e dell’asilo che .. goda di una tutela maggiormente protettiva con riguardo alla proposizione del ricorso per cassazione”.
Tale affermazione, secondo la Sezione, oltre a mancare di qualsiasi giudizio di comparazione con procedimenti analoghi in applicazione dei criteri indicati dalla Corte di giustizia (oggetto, causa, elementi essenziali), è smentita dal rilievo che sia il procedimento diretto al riconoscimento dello status di apolide, sia il procedimento in materia di riconoscimento della protezione umanitaria nei casi di cui ai D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 6, di cui alla lett. d), non prevedono alcuna “specialità” della procedura di rilascio della procura sub specie della certificazione della data a pena di inammissibilità.
Sicchè, in violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, il citato art. l’art. 35-bis, comma 13 introduce, per una determinata categoria di stranieri, un regime processuale comportante un esercizio del diritto di azione più gravoso, con riferimento alle modalità di conferimento della procura e alle severe conseguenze derivanti dalla loro inosservanza, non solo rispetto a quello riservato ai cittadini e a quello applicabile per gli altri stranieri che agiscano davanti al giudice italiano (ai quali, secondo la giurisprudenza di legittimità, è, invece, consentito il rilascio del mandato ad litem nella forma prevista dall’art. 83 c.p.c., «dovendosi presumere la loro presenza nello stato italiano, che costituisce il presupposto per la validità della procura medesima, dall’attestazione del procuratore che ne autentica la sottoscrizione»: Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 665 del 13/1/2011), ma anche all’interno delle medesime categorie di soggetti – gli apolidi, i richiedenti la protezione umanitaria – senza che tale differenziazione in pejus risulti sorretta da alcuna giustificazione logica o razionale.
Infatti, secondo l’insegnamento della Corte Costituzionale “il principio di eguaglianza comporta che a una categoria di persone, definita secondo caratteristiche identiche o ragionevolmente omogenee in relazione al fine obiettivo cui è indirizzata la disciplina normativa considerata, deve essere imputato un trattamento giuridico identico od omogeneo, ragionevolmente commisurato alle caratteristiche essenziali in ragione delle quali è stata definita quella determinata categoria di persone” (sent. n. 163 del 1993)
Invitando ancora una volta alla lettura dell’Ordinanza, va, alla fine di queste note, segnalato un ulteriore spunto di riflessione della Sezione remittente: se la mutilazione del giudizio di appello risulta coerente con l’insegnamento del giudice delle leggi in materia di doppio grado di giudizio di merito, non altrettanto può dirsi del rimedio del reclamo la cui mancata previsione non consente il diritto “ad un completo riesame del merito” ritenuto doveroso in tema di diritti fondamentali della persona (Corte cost., 18-07-1986, n. 200; Corte cost., 21-07-1983, n. 224), siano essi riferibili a cittadini, stranieri, apolidi, ovvero stranieri richiedenti asilo (art. 10 della Carta costituzionale).
Concludendo, sorge spontaneo il pensiero che la bellezza dell’Italia e della sua giustizia, sta nell’autonomia dei suoi giudici, nell’irrequietezza del loro spirito, nella loro capacità di resistere alla tentazione del precedente autorevole, per riaffermare i principi di giustizia, ritenuti – a torto o ragione- violati.