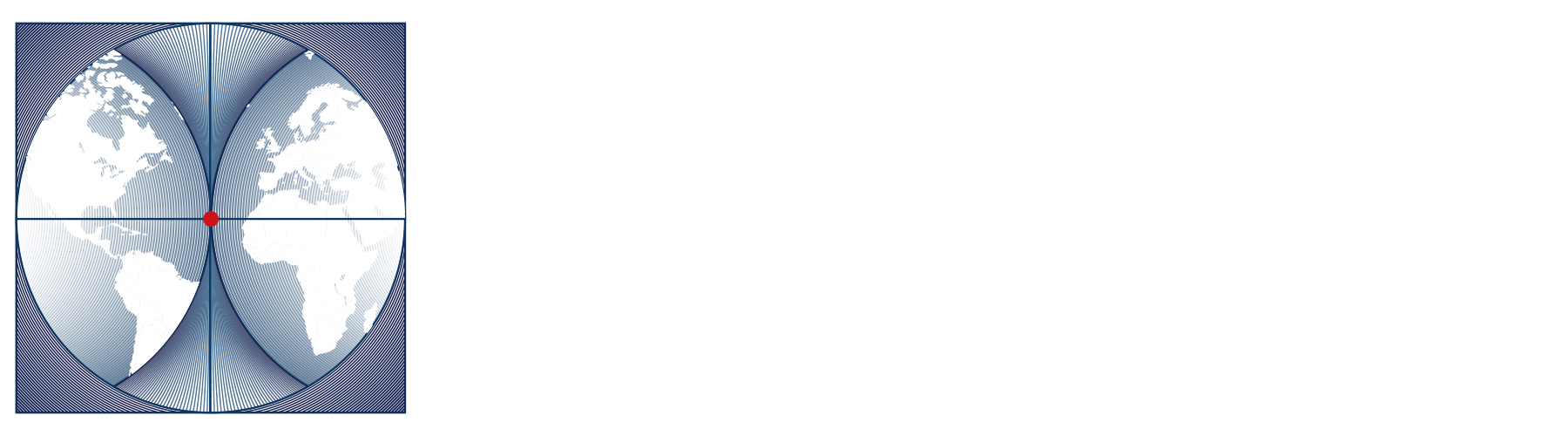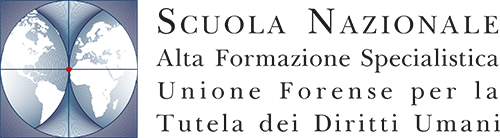Con sentenza del 30 gennaio 2025, la Corte europea dei diritti dell’uomo si è pronunciata sul caso Cannavacciuolo e altri c. Italia (ricorsi riuniti nn. 39742/14, 51567/14, 74208/14 e 24215/15), riguardante lo smaltimento illegale di rifiuti in zone della Campania.
La vicenda alla base della pronuncia riguardava lo scarico illegale, l’abbandono o l’interramento di rifiuti pericolosi su terreni privati nella zona nota come “Terra dei Fuochi”, un’area di novanta comuni nelle province di Caserta e Napoli, con una popolazione di circa 2,9 milioni di abitanti. Tali rifiuti venivano spesso bruciati, generando emissioni di diossina pericolose per la salute dei residenti. Queste operazioni erano controllate dalla criminalità organizzata e il problema era noto alle autorità almeno a partire dal 1988.
Nel corso degli anni, nell’area della Terra dei Fuochi è stato registrato un aumento dei tassi di cancro e dell’inquinamento delle falde acquifere. Ciò ha portato all’istituzione di ben sette commissioni parlamentari d’inchiesta sull’illegalità della gestione dei rifiuti nella Terra dei Fuochi e le relative conseguenze. Dalle inchieste condotte sono emersi i principali problemi legali legati alla questione, tra cui la deterrenza “praticamente inesistente” da parte delle autorità, la mancanza della “necessaria fermezza” nella risposta dello Stato, la quasi impossibilità di ottenere condanne per reati ambientali e, tra l’altro, i brevi periodi di prescrizione, accompagnati da piani di bonifica carenti e lunghi ritardi nell’agire.
I ricorsi venivano presentati, in varie date tra il 28 aprile 2014 e il 15 aprile 2015, da quarantuno cittadini residenti nelle province affette dalle operazioni di smaltimento illegale dei rifiuti e da cinque organizzazioni con sede in Campania. Invocando l’art. 2 CEDU (diritto alla vita) e l’art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare), i ricorrenti lamentavano che le autorità italiane non avevano adottato misure per proteggere i residenti dallo scarico, dall’interramento e dall’incenerimento illegali di rifiuti pericolosi nelle loro zone né avevano fornito loro informazioni al riguardo.
La Corte ha respinto, per difetto della qualità di vittima (incompatibilità ratione personae), i ricorsi presentati dalle associazioni e da alcuni dei singoli richiedenti che non vivevano nei comuni ufficialmente elencati.
In relazione ai ricorsi ritenuti ammissibili, la Corte, riconoscendo l’esistenza di un rischio per la vita “sufficientemente grave, reale e accertabile”, che poteva essere qualificato come “imminente”, ha ritenuto che il caso rientrasse nell’ambito dell’art. 2 CEDU. La Corte ha ritenuto che le autorità italiane non avessero affrontato il problema della Terra dei Fuochi con diligenza e la tempestività rese necessarie dalla gravità della situazione, nonostante fossero a conoscenza del problema da molti anni. Lo Stato italiano, ad avviso della Corte, non ha fatto tutto ciò che era richiesto per proteggere le vite dei ricorrenti, in particolare in relazione alla valutazione del problema, alla prevenzione della sua continuazione e alla comunicazione al pubblico interessato. In linea con un approccio precauzionale e con il fatto che il problema dell’inquinamento era noto da molto tempo, la Corte ha evidenziato che l’Italia non avrebbe potuto ignorare il proprio dovere di protezione sulla base del fatto che gli effetti precisi dell’inquinamento sulla salute di un particolare ricorrente non potevano essere accertati.
La Corte, poiché le argomentazioni relative all’art. 8 CEDU erano le stesse di quelle già decise in base all’art. 2 CEDU, ha ritenuto non necessario esaminare la questione sotto il profilo del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
In relazione al presente caso, è stata applicata la procedura della c.d. “sentenza pilota”, adottata quando la Corte di Strasburgo riceve un numero rilevante di ricorsi riguardanti la medesima situazione di violazione della Convenzione: in queste circostanze, la Corte può selezionare uno o più casi tra quelli pendenti, trattandoli in via prioritaria e successivamente estendendo le conclusioni raggiunte anche agli altri ricorsi pendenti. Questa procedura consente alla Corte di accertare non solo l’inadempimento nel caso concreto, ma anche il sottostante problema strutturale, facendo riferimento, nel caso di specie, alle carenze sistemiche che hanno caratterizzato la risposta dello Stato al problema della Terra dei Fuochi, all’elevato numero di persone colpite e all’urgente necessità di garantire loro una riparazione rapida e adeguata a livello nazionale. Sulla base di tale procedura, le misure indicate dalla Corte dovranno essere attuate senza ritardi ingiustificati e sotto la supervisione del Comitato dei Ministri.
I giudici europei hanno stabilito, all’unanimità, che l’Italia deve elaborare una strategia globale per affrontare la situazione della Terra dei Fuochi, istituire un meccanismo di monitoraggio indipendente e creare una piattaforma di informazione pubblica. Il termine previsto per tali adempimenti è di due anni, nel corso dei quali gli altri ricorsi pendenti (circa 4.700) saranno sospesi. La Corte si è riservata di pronunciarsi sul danno non patrimoniale entro e non oltre due anni dal passaggio in giudicato della sentenza, ad eccezione degli importi dovuti a titolo di costi e spese, che dovranno essere liquidati dall’Italia da subito.
La sentenza è particolarmente importante perché la Corte, discostandosi dalla sua giurisprudenza, anche recente, orientata a ricondurre analoghe fattispecie nell’alveo dell’art. 8 CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare), ha ravvisato – come sopra chiarito – la violazione del ben più grave diritto alla vita, tutelato dall’art. 2 CEDU.