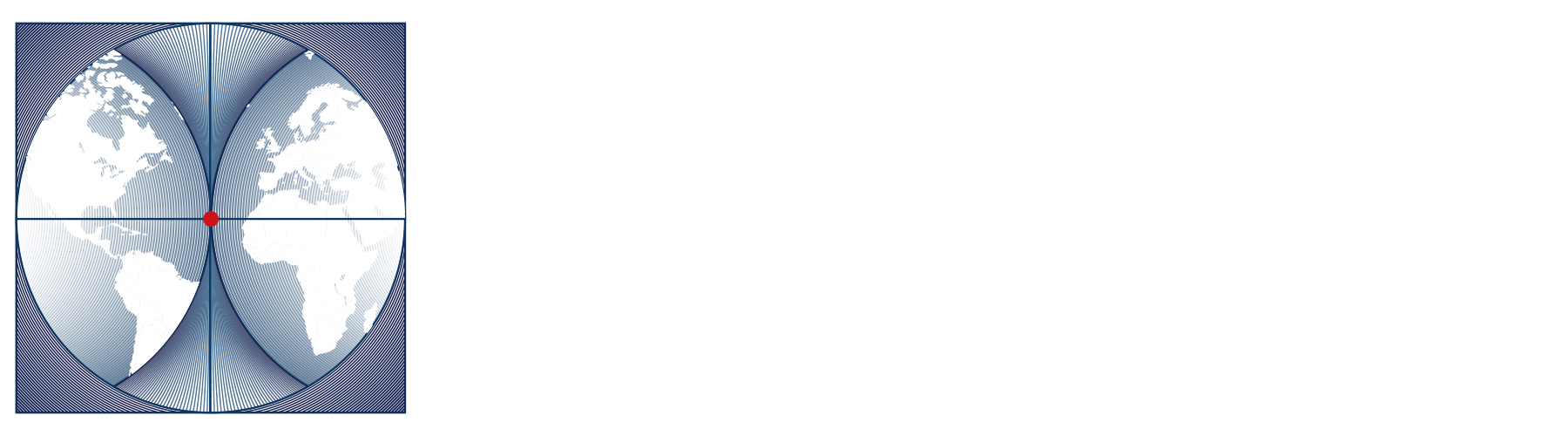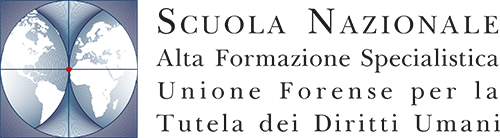di Margherita Tommasini
In Myanmar la minoranza musulmana Rohingya ha subito discriminazioni e violenze da parte della maggioranza buddista almeno dal 1962, anno in cui Ne Win prese il potere con un colpo di stato, facendo dei Rohingya uno dei più grandi gruppi di apolidi al mondo dato che solamente i buddisti potevano essere considerati dei “veri birmani”. Tale condizione è stata definitivamente ufficilizzata con una legge sulla cittadinanza del 1982, tutt’oggi in vigore.
Dopo essere stati vittima, nel corso degli anni, di varie operazioni di pulizia etnica, nel 2017 il regime militare ha scatenato una violenta persecuzione nei confronti del gruppo etnico, ricorrendo ad interventi del tutto sproporzionati rispetto alla minaccia alla sicurezza che i militari invocavano a giustificazione della loro repressione. Secondo la commissione dell’Onu incaricata del caso, tale intervento presentava un’accurata organizzazione militare che si è tradotta in una brutalità e una violenza tali da caratterizzare un piano per la distruzione della minoranza qualificabile di genocidio: molte comunità Rohingya del Rakhine (uno stato sulla costa ovest del Myanmar, in cui i Rohingya rappresentano la maggioranza della popolazione) sono state attaccate, i loro villaggi distrutti, le donne violentate, e almeno 10mila persone uccise. Dette violenze hanno inoltre costretto circa 850mila persone a prendere la fuga verso il Bangladesh, dove oggi vivono confinate in campi profughi lungo il confine col Myanmar.
La responsabilità di Facebook era stata chiamata in causa già a seguito di tali eventi e nel 2018 il social media ammetteva di non aver fatto abbastanza per prevenire l’incitamento della violenza contro i Rohingya. Il rapporto delle Nazioni Unite (A/HRC/39/64) concludeva che la piattaforma aveva svolto un ruolo cardine nella diffusione di discorsi di odio in un contesto in cui Facebook rappresentava l’unico accesso ad internet per molti utenti.
Nella recente causa presentata nel Regno Unito e negli Stati Uniti, il gruppo chiede un risarcimento danni oltre i 150 miliardi di dollari, sostenendo che l’algoritmo di Facebook ha permesso e amplificato la circolazione di messaggi di odio contro la minoranza, senza che la piattaforma ideasse meccanismi di controllo e di eliminazione dei contenuti e degli accounts in questione. Infatti, Facebook non sarebbe stato in grado di intraprendere azioni appropriate al contesto politico, nonstate fosse stato avvertito da esponenti della società civile, non monitorando tra l’altro i contenuti nelle lingue locali. In particolare, negli Stati Uniti, il gruppo accusa Facebook di essere disposto a scambiare le vite dei Rohingya con una migliore diffusione del social nel mercato birmano e pertanto è la legge del Myanmar a dover prevalere nel caso di specie, la quale, contrariamente a quanto previsto negli Stati Uniti, non dispone di previsioni che escludano la responsabilità dei social media per i contenuti pubblicati dagli utenti.
In molti accusano però la piattaforma di non aver appreso dai propri errori, restando uno strumento funzionale alla diffusione dell’incitazione all’odio e alla violenza, come ad esempio nel conflitto del Tigrè dove contribuerebbe ad alimentare, a causa di falle nel sistema di controllo, la violenza etnica che caratterizza l’attuale conflitto armato tra il governo nazionale e il Fronte popolare di liberazione del Tigrè.
I Facebook Papers, resi pubblici a partire da metà settembre, dimostrerebbero che Facebook privilegia la propria crescita a discapito della sicurezza dei suoi utenti, in particolare nei paesi in via di sviluppo, principalmente perché l’azienda non dispone delle competenze linguistiche e culturali necessarie a regolare i contenuti al di fuori degli Stati Uniti, come dimostra il moltiplicarsi di accounts e posts che incitano all’odio verso la comunità musulmana in India, dove vi sono 22 lingue ufficiali.