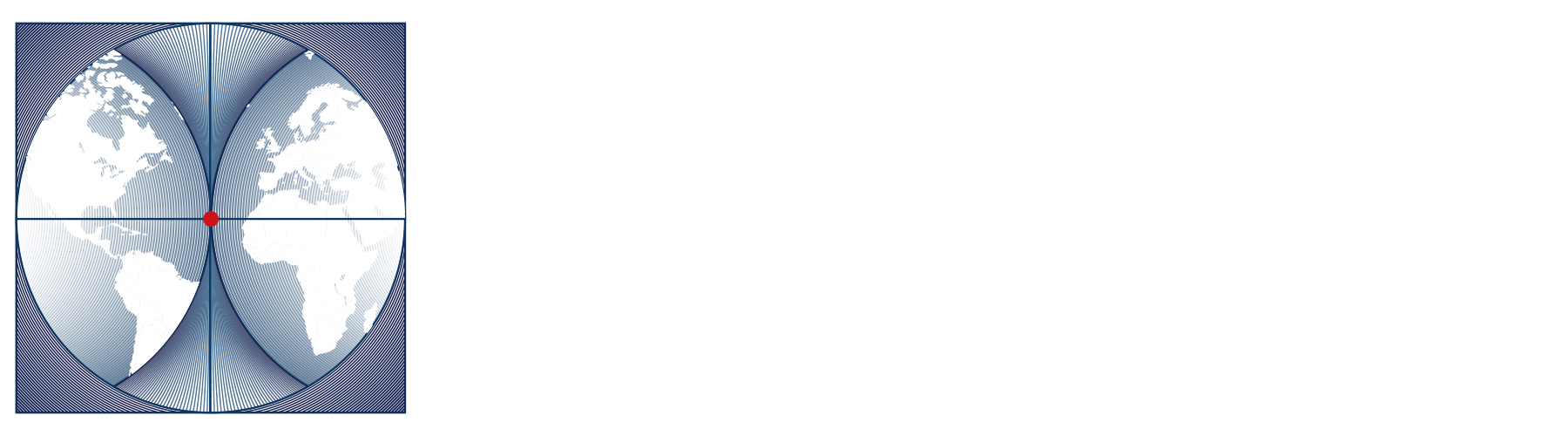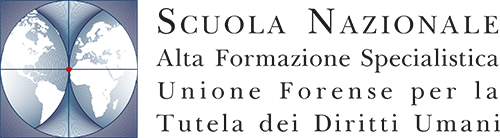Procedure giudiziarie
Caso Porta Portese
A seguito di plurime segnalazioni di annunci ed inserzioni discriminatori pubblicati sul noto periodico locale Porta Portese tra il 2006 e il 2007, all’interno dei quali proprietari di case in locazione e datori di lavoro escludevano espressamente immigrati, persone di colore e stranieri dalle loro offerte, l’Unione forense per la tutela dei diritti umani ha avviato un’azione antidiscriminatoria per denunciare le suddette discriminazioni collettive. I giudici nazionali hanno però rigettato i ricorsi interni, escludendo qualsiasi tipo di responsabilità in capo al direttore del periodico e non ritenendo configurata alcuna violazione delle norme penali dal momento che gli annunci in questione avrebbero costituto “mere proposte di contratto” espressive della “libertà negoziale in capo al soggetto dal quale provengono”. In conseguenza, l’Unione ha presentato ricorso alla Corte europea nel 2012, dove ha lamentato la violazione delle norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo relative al divieto di discriminazione ed al rispetto della privata sociale dei cittadini di colore o di origine extra-comunitaria residenti in Italia, cui gli inserzionisti hanno impedito, irragionevolmente, di accedere ad un’abitazione o ad un’attività lavorativa.
Il 6 luglio 2020, la Corte di Strasburgo ha comunicato al governo italiano il ricorso Unione forense per la tutela dei diritti umani c. Italia con l’obiettivo di accertare il contenuto discriminatorio degli annunci e delle inserzioni pubblicate sul periodico. In particolare, la Corte verificherà se vi sia stata la violazione delle norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo relative al divieto di discriminazione ed al rispetto della vita privata sociale dei cittadini di colore o di origine extra-comunitaria residenti in Italia, cui gli inserzionisti hanno impedito, irragionevolmente, di accedere ad un’abitazione o ad un’attività lavorativa.
Dopo quasi quattordici anni dall’inizio della vicenda, si apre uno spiraglio affinché venga finalmente fatta giustizia nei confronti di tutti coloro che sono stati discriminati da quegli annunci. È gravissimo che lo Stato italiano possa consentire ad un periodico di pubblicare affermazioni discriminatorie come “no persone di colore” o “solo studenti/lavoratori italiani”.
Il caso è pendente di fronte alla Corte e il Governo italiano è stato invitato a presentare osservazioni scritte in merito.
Caso Oliari e altri c. Italia
Con la sentenza del 21 luglio 2015 la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato la violazione dell’art. 8 CEDU da parte dell’Italia per aver omesso di adottare una legislazione diretta al riconoscimento e alla protezione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.
Nel caso Oliari e altri c. Italia i ricorrenti erano tre coppie omosessuali che lamentavano di essere discriminate, nel godimento dei diritti umani garantiti dalla Convenzione, sulla base del proprio orientamento sessuale. In particolare, le doglianze riguardavano il rifiuto delle autorità italiane di registrare il loro matrimonio contratto all’estero e, più in generale, l’impossibilità di ottenere il riconoscimento formale del loro rapporto, poiché la normativa italiana non permette né il matrimonio tra persone dello stesso sesso, né la conclusione di qualsiasi altro tipo di unione civile che potrebbe dare valore giuridico a simile legame. I ricorrenti hanno contestato la violazione dell’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), dell’art. 12 (diritto al matrimonio) e dell’art. 14 (divieto di discriminazione) CEDU, quest’ultimo in combinato disposto con gli articoli 8 e 12.
L’Unione forense è stata autorizzata, insieme con altre cinque ONG del network FIDH, a prendere parte come terzo interveniente al procedimento pendente, al cui svolgimento ha contribuito fornendo una memoria con un approccio comparato sulla tutela dei diritti umani in casi di discriminazione sessuale.
La Corte di Strasburgo, da un lato, ha concluso che non vi era stata violazione dell’art. 12, poiché tale norma non impone agli Stati l’obbligo di garantire alle coppie dello stesso sesso la possibilità di accedere al matrimonio; dall’altro, ha riconosciuto la violazione dell’art. 8 in quanto l’Italia non fornisce strumenti sufficienti a garantire un riconoscimento giuridico adeguato alle coppie dello stesso sesso, ignorando le indicazioni in questo senso della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione.
Scarica la sentenza
Scarica il comunicato stampa della FIDH
Caso Iseni
Il 2 settembre 2015 è stata pubblicata la sentenza del Tribunale ordinario di Roma che, dopo un’attesa di vent’anni, ha riconosciuto la cittadinanza italiana a Roberto Iseni, un apolide di etnia rom nato in Italia.
Roberto Iseni, nato in Italia l’11 ottobre 1987 da madre croata e padre serbo, fu abbandonato alla nascita a causa delle disabilità di cui è affetto. L’Unione forense, nell’ambito di un progetto finanziato da Open Society Justice Initiative, si è costituita parte terza nella causa istruita dal Sig. Iseni per ottenere lo status di apolide. Una volta raggiunto tale risultato, è stata avanzata domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana del Sig. Iseni in base alla l.91/1992, secondo cui lo straniero o l’apolide, nato in Italia e ivi residente dalla nascita, ha a disposizione un anno di tempo a partire dal compimento del 18° anno di età per presentare la dichiarazione di intenti per l’ottenimento della nazionalità italiana. La richiesta del Sig. Iseni non è stata accolta soltanto perché presentata oltre il limite di tempo previsto per legge. Gli avvocati dell’Unione forense, quindi, hanno adito il Tribunale di Roma contestando il fatto che tale ritardo fosse imputabile al ricorrente e attribuendone la responsabilità alla pubblica amministrazione che avrebbe dovuto assisterlo in una simile procedura.
Il Tribunale di Roma ha fatto propria la prospettazione degli avvocati Lana e Saccucci, riconoscendo la cittadinanza italiana al sig. Iseni. Si auspica che questo importante risultato raggiunto dalla giurisprudenza spinga il legislatore italiano a modificare la normativa vigente in materia di cittadinanza nel senso del riconoscimento dello ius soli.
Caso Smaltini c. Italia
L’Unione forense è intervenuta nel caso riguardante la morte causata dalle emissioni pericolose dell’Ilva.
L’UFTDU è intervenuta davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo come terza parte nel caso Smaltini c. Italia (appello n. 43961/09). L’appello è stato presentato dalla Sig.a Smaltini (deceduta nel 2012) e dalla sua famiglia nell’agosto 2009.
Circostanze del caso: il 12 settembre 2006 alla Sign.a Smaltini è stata diagnosticata una forma di leucemia, cui ha seguito il ricovero ospedaliero. Il 13 novembre 2006 la ricorrente ha presentato una denuncia alla procura di Taranto, sostenendo che l’inquinamento provocato dall’acciaieria Ilva, situata nella città di Taranto, era la causa della sua malattia. Il Pubblico Ministero ha deciso di archiviare il caso, così come il giudice processuale. Il giudice ha osservato che, anche alla luce delle ulteriori indagini svolte sulle circostanze del caso, il nesso di causalità tra la malattia della ricorrente e l’inquinamento prodotto dalla fabbrica non poteva essere dimostrato con un sufficiente grado di certezza.
Avendo esaurito tutti i gradi di giudizio italiano, la Sig.a Smaltini e la sua famiglia hanno presentato ricorso alla Corte di Strasburgo. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione, essi hanno lamentato che, nella nomina degli esperti, il Pubblico Ministero non ha seguito la procedura prevista dall’articolo 360 del codice di procedura penale, e che la perizia era basata su dai statistici piuttosto che sullo stato di salute della ricorrente. essi hanno inoltre lamentato che gli è stata negata una copia del rapporto degli esperti, privandoli i questo modo della possibilità di presentarlo a un medico scelto da loro stessi al fine di contestarne i risultati. Infine, hanno lamentato una violazione dell’articolo 2 della Convenzione, nesso causale tra le emissioni della fabbrica e lo sviluppo della leucemia.
L’UFTDU, in quanto terza parte, ha sottolineato il dovere dello Stato italiano di salvaguardare il diritto alla vita dei suoi cittadini,quindi la sua mancata azione nei riguardi delle emissioni inquinanti e della protezione delle vittime dell’inquinamento dell’Ilva devono essere percepite come una violazione dei suoi obblighi.
Caso Kurić e altri c. Slovenia
Con una storica sentenza emessa il 12 giugno 2012 dalla Grande Camera della Corte eurupea, il governo sloveno è stato condannato per la violazione dei diritti dei cittadini della ex Yugoslavia, i quali, da quando la Slovenia ha dichiarato la sua indipendenza nel 1991, sono stati illeggittimamente rimossi dal registro dei residenti permanenti, perdendo così ogni status giuridico.
Dopo che la Camera ha dichiarato che il rilascio dei permessi di soggiorno retroattivi costituiva un rimedio “adeguato” e “sufficiente” per le denuncie dei Sig. Petreš e Jovanović ai sensi degli articoli 8, 13 e 14 della Convenzione, e che essi non erano più considerati “vittime” delle presunte violazioni, i richiedenti hanno chiesto alla Grande Camera di ribaltare la decisione della Camera. Quest’ultima, 13 luglio 2010, ha dichiarato il governo sloveno responsabile della violazione della vita privata e familiare dei richiedenti, costretti a vivere per 20 anni con incertezza circa la loro condizione giuridica, e senza sostegno morale e materiale. Inoltre, la Grande Camera ha riconosciuto una violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea, che salvaguarda il rispetto della vita privata e familiare, e dell’articolo 13, che garantisce il diritto a un rimedio effettivo, in quanto il governo sloveno ha rifiutato di rettificare la posizione legale dei ricorrenti , in contrasto con le disposizioni della Corte Costituzionale. Inoltre, la legge adottata nel 2010 per risolvere il problema si è rivelata inadeguata. La Camera ha condannato la Slovenia anche a causa della violazione dell’articolo 14, in quanto i cittadini della ex-Jugoslavia hanno subito una discriminazione e sono stati sottoposti a un trattamento più duro rispetto agli stranieri, che hanno potuto mantenere il loro status giuridico.
Inoltre, la Corte assegnato, su base equa, EUR 20,000 a ciascun richiedente per il danno morale, e a ulteriori EUR 30,000 ai ricorrenti congiuntamente per quanto riguarda i costi e le spese affrontate.
Scarica la sentenza
Scarica la conferenza stampa dell’UFTDU
Caso Hirsi e altri c. Italia
Il 6 maggio 2009, a 35 miglia nautiche a sud di Lampedusa, le autorità italiane hanno intercettato tre navi che trasportavano 200 rifugiati somali ed eritrei (inclusi donne incinte e bambini). I migranti furono trasferiti su navi militari italiane, fatti tornare a Tripoli e consegnati alla autorità libiche contro la loro volontà, senza identificarli o ascoltarli, e sena annunciare loro la successiva destinazione.
Il respingimento va contro il principio di non-refoulement, che poribisce ad un Paese di respingere richiedenti asilo che potrebbero subire persecuzioni (art. 3 CEDU). Il respingimento costituisce anche una violazione dell’articolo 4 del Protocollo 4 della Convenzione, il quale proibisce l’espulsione collettiva degli stranieri, e l’articolo 13, il quale garantisce il diritto a un ricorso effettivo. Tra qui migranti, infatti, avrebbero potrebbero esserci richiedenti asilo, ai quali è stato negato di chiedere protezione in Italia.
Inoltre, in Libia i migranti rischiano di essere portati in centri di detenzione e di essere rimandati nei loro Paesi senza avere la possibilità di chiedere lo status di rifugiato, come prevede la Convenzione di Ginevra del 1951, di cui la Libia non è firmataria.
In sua difesa, il governo italiano ha dichiarato che la Libia era una destinazione sicura e che i migranti intercettati non hanno manifestato la loro volontà di chiedere asilo o la protezione internazionale.
I migranti respinti sono stati rappresentati dal Presidente dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani, Anton Giulio Lana, e dall’avvocato Andrea Saccucci.
Il caso ha suscitato interesse e mobilitato molte organizzazioni internazionali, come l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l’Ufficio per i diritti umani delle Nazioni Unite dell’Alto Commissario (UNOHCHR), così come altre organizzazioni non governative.
La decisone della Corte | La Corte ha condannato l’Italia per la violazione di tre principi fondamentali: la proibizione della tortura e di altre pene o trattamenti inumani o degradanti (articolo 3 CEDU), l’assenza di un rimedio effettivo (articolo 13 CEDU) e il divieto di espulsione collettiva (articolo 4, Protocollo IV CEDU). La Corte per la prima volta ha equiparato le operazioni di respingimento collettivo alla frontiera e in alto mare e l’espulsione collettiva di coloro che sono già nel Paese.
La Corte ha sottolineato che i diritti dei migranti africani sulla rotta per l’Europa sono sistematicamente violati in Libia. Inoltre, quest’ultimo non ha offerto un’adeguata protezione ai migranti che, ritornando nel loro Paese d’origine possono essere perseguitati o uccisi.
Gli standard di vita dei migranti respinti il 6 maggio 2009 in Libia erano drammatici. La maggior parte era tenuta in campi di detenzione dove venivano sottoposti a abusi e violenza. La maggioranza dei richiedenti ha ottenuto lo status di rifugiato in Libia dall’UNHCR.
Dopo che il conflitto è scoppiato in Libia, i richiedenti che ancora si trovano a Tripoli sono diventati vittime degli attacchi di rappresaglia sia da parte dell’esercito che degli insorti, e sono stati costretti a nascondersi per lunghi periodi senza avere accesso a cibo e acqua.
Dopo l’intervento della NATO, alcuni ricorrenti sono scappati in Tunisia, mentre altri hanno provato di nuovo a raggiungere l’Europa. Ad uno dei ricorrenti è stata garantita la protezione a Malta, mentre altri due sono morti cercando di raggiungere l’Italia su un’imbarcazione di fortuna. Un altro ricorrente è andato in Israele, mentre uno è tornato in Etiopia. E., uno dei ricorrenti, dopo aver viaggiato di nuovo verso l’Italia, ha ricevuto l’asilo dalla Commissione territoriale.
Sulla base delle testimonianze, è probabile che altri ricorrenti abbiano perso la vita in mare, poiché, in accordo con dati dell’UNHCR, circa 1,500 migranti sono morti cercando di raggiungere l’Italia nel 2011.
La Corte ha deciso all’unanimità che l’Italia deve risarcire i richiedenti di EUR 15,000 ciascuno per i danni morali, e di EUR 1,575.74 in totale per i costi e le spese affrontate.
Scarica la sentenza
Scarica la conferenza